Lessico del neoliberalismo Mondadori 2024 EAN 9791281543157
Lessico del neoliberalismo Mondadori 2024 EAN 9791281543157
INDICE
PREFAZIONE -Vincenzo Costa
INTRODUZIONE - La Fionda 13
POLITICA 21
Governance - Giuliana Commisso 23
Emergenza - Andrea Zhok 32
Resilienza - Marco Baldassari 39
Trasparenza - Marco Adorni 47
LAVORO, FORMAZIONE, EDUCAZIONE 55
Capitale umano - Diego Melegari 57
Competenze - Fabrizio Capoccetti 65
Imprenditorialità - Savino Balzano 74
Valutazione e competizione - Diego Giannone 82
Valutazione e controllo - Valeria Finto 92
ECONOMIA 103
Mercato - Vladimiro Giacché 104
Concorrenza - Eugenio Pavarani 112
Economia sociale di mercato - Alessandro Somma 121
Debito e sostenibilità - Emanuele Puglisi 127
Transizione ecologica - Paolo Cacciati 140
TECNOLOGIE 149
Smart - Antonio Mortone 150
Intelligenza artificiale - Teresa Numerico 156
Digitalizzazione - Matteo Falcone 168
CULTURA 175
Globale - Geminello Preterossi 177
No borders - Marco Adorni 186
Woke - Lorenza Serpagli 193
AUTORI
PRESENTAZIONE DELL'EDITORE
Il linguaggio taglia il reale, impone una logica, un’interpretazione degli eventi, li trasfigura. Il linguaggio è sempre un’operazione egemonica, e il potere neoliberale si è potuto dispiegare perché ha imposto un linguaggio, un lessico che orienta lo sguardo, che impone come e di che cosa parlare. La lotta contro il neoliberalismo è dunque oggi anche una lotta nel linguaggio, per la quale questo libro collettivo è un prezioso strumento. Con interventi di Marco Adorni, Marco Baldassari, Savino Balzano, Paolo Cacciari, Fabrizio Capoccetti, Giuliana Commisso, Vincenzo Costa, Matteo Falcone, Vladimiro Giacché, Diego Giannone, Antonio Martone, Diego Melegari, Teresa Numerico, Eugenio Pavarani, Valeria Pinto, Geminello Preterossi, Emanuele Puglisi, Lorenza Serpagli, Alessandro Somma, Andrea Zhok.
PREFAZIONE
Vincenzo Costa
Il dominio non si è mai espresso attraverso mere forme coercitive e questo è a maggior ragione vero per l’epoca attuale. Il dominio autentico richiede egemonia, capacità di imporre il proprio punto
di vista come uno sguardo universale, presentando interessi, valori e modi di vivere particolari come espressione della ragione e del buon senso in quanto tali. Questa egemonia è necessaria per legittimare l’esercizio del potere, il privilegio di alcuni gruppi, ma perché essa possa dispiegarsi sono necessarie pratiche sociali che modifichino non solo le credenze, i punti di vista e le narrazioni: bisogna modificare i modi di sentirsi e di sentire l’esistenza, il proprio essere sociale e l’essere con gli altri.
Tra le pratiche sociali attraverso cui l’egemonia può dispiegarsi, il linguaggio svolge un ruolo fondamentale. Imporre un linguaggio significa imporre uno sguardo sul mondo, determinare il recinto
entro cui si può e si deve pensare, ciò che può essere detto e ciò che, senza alcuna censura, diventa sconveniente dire. Nella pratica egemonica del linguaggio alcune espressioni escono dalla sfera discorsiva: non ricorrono più nel linguaggio parlato, si interrompe la memoria culturale perché si interrompe la memoria comunicativa.
Negli ultimi quarant’anni sono tante le locuzioni divenute impronunciabili.
In questo modo esse sono uscite dal discorso pubblico.
E tuttavia, forse non è del tutto vero che dove non esiste la parola non esiste la cosa. Non si è più parlato di sfruttamento, ma è dubbio che la cosa stessa sia sparita con il declino della parola, così
come mai come in questi decenni c’è stata lotta di classe, anche se a condurla è stata la classe dominante che, giorno dopo giorno, ha eroso tutte le conquiste sociali raggiunte dalle classi dominate in un secolo di lotte.
Questa lotta di classe, tuttavia, non sarebbe stata vincente se non avesse avuto successo come lotta di classe nel discorso. Il neoliberalismo ha potuto dispiegarsi perché ha imposto la propria visione
del mondo e della vita modificando il linguaggio, a volte inventando nuovi termini, a volte risemantizzando termini antichi, a volte producendo aggettivazioni che conferiscono un senso positivo a termini negativi. Così, il termine «capitalismo», che rimanda immediatamente
al dominio di chi detiene il «capitale», cede il posto a un termine quasi neutro come «mercato», inteso come un meccanismo anonimo, una sorta di dio che distribuisce punizioni e premi,
per esempio quando si dice «quella scelta è stata punita dai mercati». In questa maniera è stato possibile occultare lo svuotamento degli istituti parlamentari, dato che questi, nel loro legiferare,
devono tenere conto del volere del dio mercato. Questo viene teologizzato, diventa l’espressione della ragione. Il linguaggio impone di parlare della «razionalità dei mercati», non di fondi di investimento, non di speculatori finanziari che scommettono contro la società e i cui interessi sono opposti a quelli delle comunità di persone.
Ma il linguaggio deve soprattutto generare la colpa, deve fare sentire colpevoli coloro che appartengono alla classe dominata. E così, coloro che non intendono conformare le loro vite alle esigenze di una produzione fine a sé stessa, utile all’accumulazione piuttosto
che alle persone e alle comunità, divengono «gli sconfitti della globalizzazione», coloro che non hanno abbastanza «resilienza»: divengono degli esseri deficitari, colpevoli, inferiori. L’esigenza
di giustizia sociale diviene «invidia sociale».
Il linguaggio taglia il reale, impone una logica, un’interpretazione degli eventi, li trasfigura. Il linguaggio è sempre un’operazione egemonica, e il potere neoliberale si è potuto dispiegare perché ha
imposto un linguaggio, un lessico che orienta lo sguardo, che impone come e di che cosa parlare. Ha potuto dispiegarsi come strategia di potere perché ha modificato il senso delle parole, impedendo
che queste dicessero il movimento reale, togliendo voce a intere fasce sociali. Ma il reale che non ha più avuto accesso alla parola non è svanito. Semplicemente non ha più avuto voce, e
dunque ha dovuto trovare proprie forme di espressione che restano ancora da decifrare e da capire.
Questa operazione egemonica prodotta nel e attraverso il linguaggio è giunta oggi al capolinea, giorno dopo giorno sta perdendo ogni capacità egemonica, rivela tutto il suo portato ideologico.
Il lessico neoliberale mostra di essere un linguaggio che, invece di fare vedere il possibile, lo copre e lo occulta. La lotta è dunque oggi anche una lotta nel linguaggio, è necessario decostruire questa
operazione ideologica, mostrare gli spostamenti di senso attraverso cui abbiamo perso un linguaggio capace di dare voce al reale e alle persone che lo abitano.
I saggi raccolti in questo volume aprono questo spazio decostruttivo, portano alla luce gli spostamenti di significato attraverso cui è stato possibile imporre come razionale e universale una narrazione
particolaristica e di potere. Essi rappresentano pertanto uno strumento indispensabile per chiunque voglia accostarsi criticamente alla politica contemporanea, che è fatta anche di parole attraverso
cui si guarda il reale.
Ma la pubblicazione di questo volume è anche un segno che indica una trasformazione di proporzioni più ampie. Solo un decennio fa la sua apparizione non sarebbe stata possibile, tanto era pervasiva
e diffusa la narrazione neoliberale. Essa era l’ovvietà e l’evidenza stessa. Oggi, al culmine del suo potere (economico, politico, accademico, mediatico) ha cessato di esserlo.
Che questo libro e questi contributi appaiono indica che lo spirito del tempo sta cambiando, che nuovi concetti stanno venendo forgiati, che un pensiero nuovo è in cammino, che c’è una vita e un
mondo della vita che stanno cercando di accedere al linguaggio
L’epoca del pensiero neoliberale e «progressista» si sta chiudendo, e forse si è già chiusa. Chiusura non significa, tuttavia, fine. Essa può durare ancora a lungo, ma il periodo della sua egemonia culturale è alle nostre spalle. Questi saggi parlano già da un altro luogo.
PRESENTAZIONE DE LA FIONDA
LA FIONDA Antonio Semproni
In “Lessico del neoliberalismo. Le parole del nemico” (Autori vari de La Fionda, Rogas, 2024) sono commentati i termini e le espressioni che la cultura neoliberale ha coniato o di cui si è appropriata, risemantizzandoli, per costruire un senso comune trasversale al tessuto sociale e perciò atto a negare la pensabilità di un’opposizione all’ordine neoliberale o comunque di una trascendenza di quest’ordine.
Questi termini ed espressioni corrispondono a concetti che Herbert Marcuse riterrebbe operativi, cioè la cui descrizione si esaurisce in una serie di operazioni e, tramite queste, in una o più funzioni. I concetti operativi designano quindi la cosa nella sua funzione, realizzando un’identificazione tra cosa e funzione, per cui attributo precipuo della prima è il suo ruolo servente l’ordine esistente. Così, per esempio, l’economia sociale di mercato dovrebbe soddisfare i bisogni sociali e le tecnologie smart dovrebbero risultare sempre e comunque intelligenti e pertanto profittevoli all’uomo.
L’operazionismo – cioè la definizione dei concetti in senso operativo – astrae dalla cosa in sé, dal complesso delle sue potenzialità che, se estrinsecate, la porrebbero in una relazione rinnovata con l’insieme di altre cose che compongono l’ordine esistente: una relazione che potrebbe anche assumere tratti conflittuali. Il concetto operativo rimuove dunque dalla cosa qualsiasi portata negatoria dello status quo o anche solo ostativa alla direzione indicata dal progresso. Così, per esempio, il concetto di concorrenza, se consideriamo l’etimologia del termine, indica l’azione di correre insieme e dunque dovrebbe escludere la competizione senza scrupoli tra gli operatori economici, dando piuttosto adito o a una regolamentazione statale che detti loro i tempi e i modi di realizzazione del bene comune o, addirittura, a una collaborazione orizzontale tra di essi.
Pensare in maniera operativa è un tipico atteggiamento positivista, volto a rimuovere qualsiasi latente contraddizione dall’ordine stabilito, affinché possano attecchire i semi del progresso illimitato. Così il concetto di globalizzazione, inteso come mondializzazione del mercato, non solo ha schiacciato nella pratica quello di internazionalismo, che indica invece la solidarietà delle classi che rivestono una posizione subalterna entro lo stesso mercato, ma, soprattutto, viene visualizzato nel senso comune dominante a prescindere dal suo antagonismo con esso, come se non ne costituisse la negazione. Marcuse spiega bene come la razionalità tecnologica – cioè la razionalità che crede nel completo assoggettamento della natura da parte della tecnica, fino ad addivenire all’amministrazione del tutto – non comprenda, nel suo strumentario logico, l’alternativa parmenidea tra essere e non-essere né la dialettica platonica tra idee e apparenze percepibili: essa sussume soltanto il principio aristotelico di non contraddizione, secondo cui una certa proposizione e la sua contraddizione non possono essere entrambe vere; così, rimosse l’opposizione e la trascendenza, la datità assume uno statuto ontologico e il solo motore della società resta quello evoluzionistico: la fede nel progresso è fede nella stessa struttura sociale che reca in seno la promessa dell’evoluzione del mondo e delle sue cose.
Ecco brevemente illustrate le parole oggetto di approfondito studio nel libro, che, giustapposte l’una all’altra, costituiscono l’impalcatura di tale struttura sociale e la bussola per orientarsi in esso e comprendere le sue dinamiche profonde.
La “governance”, lungi dal costituire sinonimo di un governo rappresentativo e democratico, dipendente in altre parole dalla dialettica parlamentare, è un dispositivo per gestire la cosa pubblica secondo le tecniche manageriali del settore privato; ciò importa, entro l’amministrazione pubblica: l’affidamento delle attività di gestione al management e dunque ad amministratori delegati piuttosto che a organi politici; l’introduzione del principio di concorrenza nei servizi pubblici, tramite gare d’appalto che costringono i fornitori della cosa pubblica a competere fra loro; la previsione di incentivi al raggiungimento di determinati risultati, dunque di meccanismi premiali volti a stimolare l’imprenditorialità; la gestione della spesa pubblica sulla base di criteri che riflettono non i bisogni sociali, ma la qualità del servizio. L’implementazione della governance nel settore pubblico è dovuta ai governi neoliberali di Thatcher e Reagan, che la concepirono come risposta alla crisi fiscale dello Stato, ma già negli anni trenta del novecento i pensatori ordoliberali tedeschi, rimettendo in questione le funzioni dello Stato sull’onda del timore per l’inflazione che aveva destabilizzato la Repubblica di Weimar, immaginavano il principio di concorrenza quale regolatore dell’intera vita sociale; il loro quadro è stato sussunto nell’architettura delle istituzioni europee, che riconoscono un’economia “altamente competitiva” (come recita il Trattato di Lisbona) e il principio di sussidiarietà, che dà il là a una continua ibridazione fra pubblico e privato nel soddisfacimento dei bisogni sociali.
L’“emergenza” è chiamata in causa dai governi neoliberali per suscitare una reazione collettiva condivisa laddove la società non si muove più verso un orizzonte di senso condiviso, sotto cioè il segno di un’escatologia che contiene una promessa per tutti, ma è frammentata in un’addizione di individui ciascuno dei quali persegue autonomamente i propri personali interessi e dunque si trova in competizione con gli altri; lo spettacolo mobilitato entro lo scenario emergenziale riscuote l’approvazione pubblica in società marcatamente individualistiche, dove la sfera civica è poco coltivata ed è dunque agevole strumentalizzare il panico pubblico. L’embrione dell’emergenza era presente già nello Stato liberale: i consociati si assoggettano alla sovranità statale per sfuggire alla reciproca minaccia che essi rappresenterebbero gli uni per gli altri nello stato di natura. La posta in gioco quando si chiama in causa un’emergenza non è soltanto la compressione di diritti fondamentali ma anche, e forse soprattutto, la rilegittimazione e anzi l’ampliamento della legittimazione del potere costituito, la cui configurazione eccezionale risulta indispensabile proprio per scongiurare la minaccia. Tramite questa compressione si riesce, senza dover rendere alcuna spiegazione eccetto la supposta esistenza di un pericolo, a intervenire capillarmente nelle nostre vite, così implementando al massimo grado l’arte di governo della biopolitica.
La “resilienza” è una parola d’ordine della dottrina neoliberale che l’ha mutuata dalle scienze naturali, nel contesto delle quali indica la capacità dei metalli di assorbire i colpi. Applicata all’individuo neoliberale, essa esige da costui il continuo adattamento alle crisi sistemiche e alle oscillazioni del mercato del lavoro. Spronare alla resilienza implica dunque disconoscere le cause politiche delle crisi (segnatamente, delle dinamiche inflative e delle conseguenti politiche di austerità con ondate di disoccupazione), nonché indicare nell’adeguamento di sé alle precarie condizioni socio-economiche e nella predisposizione a cavalcare l’incertezza e l’instabilità la sola strategia praticabile per allontanare lo spettro del fallimento personale; in questo contesto, viene perseguito nel silenzio generale lo smantellamento dello Stato del benessere e della sua triplice funzione “previsione-prevenzione-protezione”.
La “trasparenza” è un principio veicolato tramite la diffusione dei social media e la digitalizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini: esso informa sia i rapporti orizzontali che la dialettica tra autorità e libertà. Circa i primi, ha assuefatto le persone a una fruizione accelerata di un gran novero di informazioni: questo flusso comunicativo dovrebbe garantire l’eliminazione di ogni traccia di ombra e segreto dal mondo, in particolare dalla sfera politica, e creare così un essere umano edotto su tutto, ma incapace di ragionare, di porsi questioni sull’eventuale occultamento di trame del potere repulsive al bagliore dell’informazione. Questa incapacità è evidentemente correlata all’impossibilità di concepire un’alternativa all’ordine neoliberale: la società che si offre nella totale trasparenza assorbe l’attenzione e le energie mentali dei consociati, che finiscono per smarrirsi nei vasti campi in cui la stessa società è articolata. Quanto alla dialettica autorità-libertà, quest’ultima, piuttosto che incarnarsi nel “controllo uno-molti dello Stato tradizionale”, viene disarticolata in innumerevoli poli di controllo: ciascuno di noi si espone, si offre nella propria trasparenza allo sguardo di tutti gli altri; questa pubblicizzazione della persona umana costituisce una violenza totalitaria giacché nega “al soggetto ogni possibile soggettivazione, dal momento che gli è stata tolta la possibilità di esercitare il riserbo, la distanza, l’oscurità di significati, l’ambiguità e la discrezione”.
Per “capitale umano” può intendersi l’insieme di attitudini, talenti, qualifiche ed esperienze accumulate da un individuo e determinanti la sua capacità di lavorare e produrre; alla luce di questa definizione, le spese in educazione, formazione e cure mediche possono essere considerate un investimento. L’istruzione diviene così un portfolio di competenza trasversali da rimodulare continuamente per adattarsi alla competizione. Anche le relazioni sociali instaurate o da instaurare vengono valutate in termini di capitalizzabilità, cioè per quanto stanno rendendo o potranno rendere. La persona che incorpora questo complesso di nozioni si costituisce imprenditore di sé, desidera, in altre parole, quanto la sfrutta: la sua cittadinanza acquista i tratti della managerialità, essendo i diritti a essa connessi continuamente esposti alla declassazione.
Il vocabolo “competenze” si collega strettamente al capitale umano, in quanto implica la riduzione dei saperi a fattori di produzione e ben risponde dall’imperativo dell’adattamento. Se le competenze sono credenziali immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, allora l’educazione si riduce a servizio reso al mondo economico: è così che la scuola sta rimodulando le offerte formative per trasmettere, anziché un sapere, un saper-agire, cioè l’utilizzo efficace di quanto appreso nella vita lavorativa, e abituare gli studenti a imparare a imparare, cioè ad adeguare il proprio sapere a quanto esige il mercato del lavoro.
Il modello di “imprenditorialità” che si impone in questo contesto valoriale fa strame dei limiti imposti alla libertà di iniziativa economica in Costituzione; effettivamente, la sovrastruttura giuridica che recepisce il compromesso tra capitale e lavoro raggiunto nel “trentennio glorioso” ha incominciato a incrinarsi già sotto la sferza di interventi come la Legge Fornero o il Jobs Act.
La “valutazione” costituisce un dispositivo della governance neoliberale che, mirando a quantificare il valore di cose, persone ed enti, li ordina entro una classificazione gerarchizzata, cioè in una vera e propria classifica che li rende comparabili tra loro. Rendere pubblica quest’ultima (come avviene, per esempio, con riferimento alle valutazioni assegnate dalle agenzie di rating ai titoli del debito pubblico) permette a investitori e consumatori di orientare le proprie scelte e sprona il valutato a competere, cioè a ottenere una misurazione del proprio valore che sia più elevata di quella ottenuta dagli altri concorrenti. In tal modo la valutazione legittima la distribuzione della ricchezza, nonché la premialità del merito, e dunque giustifica le diseguaglianze. Essa è difficilmente attaccabile in quanto si presenta come “espressione di un processo oggettivo” e tende perciò a favorire forme depoliticizzate di decisione, guidate non da valori ideali ma dal valore economico.
Presupposto della valutazione è il “controllo”; la tendenza che si riscontra negli Stati neoliberali è quella di incorporare il controllo nella medesima organizzazione o persona fattane oggetto, affinché costei si impegni in un processo di self-audit e si renda trasparente e disponibile al monitoraggio di sé. Si tratta di indurre gli individui a comportarsi conformemente alle norme entro uno spazio che viene concesso loro dichiaratamente per introdurre un sovrappiù di libertà ma in realtà per assoggettarli a un sovrappiù di controllo (lo spazio digitale, e in particolare i social media, sono emblematici di questo meccanismo di coazione indiretta, di biopolitica governamentale). Entro questo contesto, si parla di Stato valutatore, la cui fonte di legittimazione sta nella potenza di misurazione e quantificazione.
La parola “mercato” viene spesso utilizzata per indicare un soggetto razionale, dotato del potere di sanzionare quelle decisioni di politica economica confliggenti con la propria razionalità (perlopiù protezionistiche o comunque di segno contrario alla liberalizzazione), anche se il mercato non è altro che il risultato della convergenza di volontà individuali (gli animal spirits); tuttavia, l’entificazione operata da stampa e istituzioni finanziarie consente di presentare le sue dinamiche come ineluttabili e di farlo assurgere a un totem. Talvolta esso viene però presentato come un soggetto tutt’altro che razionale: si pensi alle espressioni “effetto gregge” o “panico sul mercato”. In ogni caso, quel che è certo è che il mercato indica il sistema capitalistico in quanto imperniato sulla proprietà privata: questo significato è evidente tutte le volte in cui le privatizzazioni vengono salutate come la restituzione delle società controllate dal settore pubblico al mercato; simile atteggiamento presuppone la fuoriuscita dall’economia mista e l’uso del termine “mercato” anziché “capitalismo” consente di rendere più digeribile l’inversione di rotta.
Il concetto di “concorrenza” affonda le proprie radici nel pensiero economico classico – nato in parallelo alla rivoluzione industriale –, secondo cui il libero esercizio della rivalità concorrenziale è in grado di tradursi nel benessere sociale favorendo la massimizzazione della produzione e dunque della ricchezza collettiva e stabilendo – proprio per via della concorrenza tra gli imprenditori, che si spostano da settori meno remunerativi a settori più profittevoli – a un equilibrio dei prezzi favorevole ai consumatori. Tuttavia, non è mai stato dimostrato secondo una logica razionale e argomenti empirici come la somma e l’interazione degli interessi individuali possa generare un risultato rilevante sul piano del bene comune. Il culmine di questa linea di pensiero è stato concepito dalla teoria economica marginalista, secondo cui un mercato perfettamente concorrenziale (ove ciascun operatore dispone di informazioni complete sulla condotta degli altri e i prodotti scambiati sono omogenei) è in grado di generare una distribuzione “naturale” del reddito: da questo quadro si dileguano la politica e il conflitto distributivo che essa è deputa a comporre.
La locuzione “economia sociale di mercato” fu coniata nella Germania del secondo dopoguerra da Alfred Müller-Armack, persona vicina, oltreché agli USA, al ministro dell’economia dell’allora governo cristianodemocratico di Konrad Adenauer; in questo modello economico sono contemplati interventi statali volti a implementare lo sviluppo della concorrenzialità e pertanto miranti a sanzionare i cartelli tra imprese e i monopoli, che rappresentano indebite concentrazioni di potere economico; anche il sindacato è inteso come un’indebita concentrazione di tale potere e per questo se ne devono spuntare le armi. Sia nel Trattato per la riunificazione di Germania Ovest e Germania Est che nel Trattato sull’Unione Europea l’economia sociale di mercato figura fra i principi fondamentali e questa inclusione induce molti commentatori a erroneamente ritenere che si stia mediando tra istanze neoliberali e istanze sociali.
Il “debito” è un’altra parola chiave dell’impianto economico neoliberale perché consente di moralizzare il soggetto debitore, in particolare lo Stato, colpevolizzandolo se non saprà ripagare i propri creditori. Accoppiata al debito, la stabilità indica il grado di affidabilità (anche qui torna un accento moralistico) di un’economia nazionale, misurata dalla sua capacità di tenere i conti in ordine e di garantire la solvibilità dei debiti esteri. Questa endiadi produce quali imperativi politiche deflattive, privatizzazioni e concorrenzialità, e nell’ordinamento politico dell’Unione Europea si è tradotta nel Patto di stabilità, in base al quale gli Stati membri sono tenuti ad adeguare tanto il bilancio quanto il loro rispettivo totale indebitamento a determinati parametri percentuali, commisurati al PIL. Sappiamo bene quel che segue all’inottemperanza a questi ultimi: nel 2011 in Italia venne decretata la fine del governo Berlusconi, giudicato incapace di adottare le riforme strutturali necessarie a ridurre il debito, mentre nel 2015 la Grecia fu sottoposta a un piano di salvataggio “lacrime e sangue”, che peraltro aveva incontrato l’opposizione del popolo, accusato di “aver vissuto al di sopra delle proprie possibilità”.
Altro concetto inerente alla struttura economica è quello di “transizione ecologica”. L’etimo del termine – che viene dal latino transire – implica il passaggio da uno stato a un altro, dunque un processo trasformativo reale, un cambio del paradigma economico; una transizione ecologica sincera esigerebbe quindi un arretramento della crescita economica onde consentire la cura dell’ambente e ridurre lo spazio antropizzato che l’umanità occupa nel mondo. Quella che si sta affermando è però una transizione ecologica dall’alto, ove la crescita economica resta al centro e la protezione dell’ambiente naturale viene inserita nei calcoli costi/benefici delle imprese, il che importa la finanziarizzazione della sostenibilità, cioè la permeabilità della tutela dell’ecosistema ai meccanismi di debito e compravendita tipici del mercato (dalle obbligazioni ESG fino allo scambio dei permessi di inquinamento).
La parola “smart” si riferisce ai dispositivi digitali e a quelli animati dall’intelligenza artificiale. All’intelligenza degli ultimi ritrovati della tecnologia fa da contraltare un consumismo ottuso (oltreché insostenibile per l’ambiente), scatenato da un ciclo rapido e perpetuo di sostituzioni e aggiornamenti, e l’erosione della nostra autonomia individuale. Inoltre, l’affidamento agli algoritmi di decisioni su questioni come l’accesso al credito o la selezione dei candidati a un posto di lavoro non solo implica la nostra deresponsabilizzazione ma può portare anche a perpetuare e amplificare le disuguaglianze, considerato che l’addestramento degli algoritmi avviene su dati concreti e quindi agevola la proiezione del passato sul futuro.
La “digitalizzazione”, dietro la promessa della creazione di uno spazio alla portata di tutti per l’accesso alle informazioni e, di conseguenza, l’esercizio della partecipazione democratica, ha creato un oligopolio di aziende della tecnologia che traggono profitti dall’estrazione ed elaborazione algoritmica dei nostri dati personali.
L’aggettivo “globale” qualifica invece quel processo di omogeneizzazione delle differenze politiche, culturali e di costume tra i popoli condotto sotto il segno della duplice teologia economica – espansione mondiale del mercato – e giuridica – la strumentalizzazione dei diritti umani per esportare democrazia, cioè per giustificare guerre mirate al controllo delle materie prime o all’apertura dei mercati terzomondisti –; a condurre simile iniziativa è l’Occidente, con gli Stati Uniti a reggere il gonfalone, cosicché si può concludere che la globalizzazione corrisponde a un ordine geopolitico unipolare, laddove il multipolarismo che sta di recente prorompendo ne segna la crisi.
La parola “confine”, nel suo autentico campo semantico, costituisce una garanzia di stabilità, in quanto presuppone che insieme (“con”) si ponga una fine (“finis”) a una traiettoria espansiva foriera di ostilità. Studi sociologici di ultima generazione, noti come border studies, hanno posto le fondamenta per una assimilazione del confine alla frontiera, significante che allude al movimento, alla scoperta e al progresso, ma anche alla colonizzazione e allo sfruttamento: il confine è stato così reinterpretato come frontiera mobile. I confini nazionali, stabili e netti, vengono di conseguenza tacciati di arbitraria artificiosità, se non di configurarsi quale strumento di discriminazione: questa impostazione disconosce la storia e la tradizione politica dei popoli, senza risparmiare nemmeno l’autodeterminazione nazionale dei movimenti anticoloniali, e serve l’universalismo della ragione neoliberale.
Similare distorsione ha subito la parola “woke”, che all’inizio del ventesimo secolo costituiva una raccomandazione, interna alla comunità afroamericana, a stare in guardia (woke è una versione contratta di awake, sveglio) dalle ingiustizie sociali e razziali. Il termine è stato movimentato entro lo spazio digitale fino a usurarsi e limitare il proprio ambito semantico alle sole ingiustizie culturali e identitarie; a quel punto, la ragione neoliberale – e i suoi agenti, sotto forma di aziende e imprenditori digitali – hanno scimmiottato le posture woke onde aggiudicarsi consensi e disinnescare il potenziale rivoluzionario delle istanze originariamente sottostanti a questo movimento culturale.
Chi leggerà “Lessico del neoliberalismo. Le parole del nemico” potrà legare tutte queste parole con un filo rosso e rendersi conto che questo delimita il perimetro di un ordine sociale tutt’altro che accogliente, essendo inclusivo solo nella misura in cui un’ulteriore inclusione corrisponda a specifici interessi di parte.
LA FIONDA Eugenio Pavarani
Le parole del neoliberalismo
di Eugenio Pavarani
Presentazione del libro “Lessico del neoliberalismo. Le parole del nemico”, Rogas Edizioni, 2024
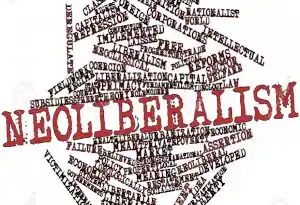 Prima di entrare nel merito dei contenuti del libro, devo dare una indicazione preliminare, importante quando si presenta un libro. I libri si possono dividere in due categorie: i Libri (con la elle maiuscola) e i libroidi (con la elle minuscola). Quindi comincio col dire che questo è un Libro. La classificazione non è mia. È di Carlo Galli. Mi è piaciuta e la faccio mia.
Prima di entrare nel merito dei contenuti del libro, devo dare una indicazione preliminare, importante quando si presenta un libro. I libri si possono dividere in due categorie: i Libri (con la elle maiuscola) e i libroidi (con la elle minuscola). Quindi comincio col dire che questo è un Libro. La classificazione non è mia. È di Carlo Galli. Mi è piaciuta e la faccio mia.
Galli però non ha dato una definizione di libro e di libroide. Io la vedo così: leggere un Libro è come indossare un paio di occhiali speciali che ti fanno vedere qualcosa che senza quegli occhiali non avresti visto, vedi qualcosa di nuovo e di interessante, qualcosa che ti arricchisce. Un libroide invece non ti fa vedere niente di nuovo, niente che non fosse già visibile e già visto. Ricordo la recensione che fece un autorevole barone accademico che voleva stroncare una monografia di un giovane ricercatore. In realtà voleva stroncare i maestri di quel ricercatore e la loro scuola: voleva colpire il ricercatore per colpire i suoi maestri. Disse il barone: il libro propone idee nuove e idee interessanti; purtroppo però le idee interessanti non sono nuove e le idee nuove non sono interessanti. Parole come pietre: libroide colpito e affondato.
Detto che “Lessico del neoliberalismo” è un Libro e non è un libroide, devo evidenziare cosa si vede di nuovo e di interessante attraverso questo libro; cosa consentono di vedere gli occhiali speciali offerti dal libro. Per arrivarci devo fare una premessa.
Un anno fa Marco Baldassari e Marco Adorni mi parlarono del progetto editoriale che poi ha dato vita a questo libro. Il progetto di cui mi parlarono consisteva nell’elaborazione di un glossario del neoliberalismo. Mi invitarono a portare un contributo e mi affidarono il lemma “concorrenza”. Mi è parsa subito un’idea originale e molto interessante.
Del neoliberalismo si è scritto in tanti modi ma indubbiamente mancava un glossario ragionato che ci aiutasse a capire come parla il neoliberalismo, che parole usa, come si propone di convincerci attraverso le sue narrazioni, attraverso le sue parole. Un libro che ci facesse capire che le parole sono importanti. Un libro che ci facesse capire che, se usiamo le parole del potere, facciamo il suo gioco e abbiamo perso in partenza.
Se vogliamo opporci a questa ideologia egemonica e narcotizzante che ha permeato di sé l’intera società, dobbiamo svegliarci e, per prima cosa, dobbiamo resettare il nostro lessico; dobbiamo essere critici nell’uso delle parole; dobbiamo vagliare le parole alla luce di un principio di verità e alla luce di un principio di civiltà. “Le parole sono importanti”. Questa affermazione l’avevo già sentita; fu la prima cosa che mi venne in mente. Nella mia mente il libro nasceva insieme a quella affermazione. Sono partito da lì e ho pensato di far partire da lì anche questa mia breve presentazione. Sono parole di Nanni Moretti: https://youtube.com/watch?v=dUXIh3SJhFA%3Ffeature%3Doembed
Perché parto da Nanni Moretti? Anzitutto perché il libro, per come è fatto, non è riassumibile. Non avrebbe senso indicare al potenziale lettore il contenuto delle analisi proposte dai singoli autori in merito alle venti parole del libro. Il riferimento a Moretti mi offre lo spunto per cercare di mettere in evidenza il messaggio di fondo che lega i diversi contributi. Vedo nelle parole di Moretti una forte connessione con questo libro e credo che la citazione della sua affermazione “le parole sono importanti” avrebbe potuto costituire l’esergo del libro. La vedo così: Moretti propone la traccia del tema in termini generali e il libro può essere interpretato come lo svolgimento del tema in termini specifici, cioè in riferimento al neoliberalismo. Tema: le parole sono importanti. Svolgimento: il lessico del neoliberalismo.
Ho pensato pertanto di ancorare la mia esposizione alla traccia proposta nel video e seguirò un indice espositivo derivato dalle parole di Moretti:
- come parli?
- le parole sono importanti
- chi pensa male parla male
- bisogna trovare le parole giuste
- D'Alema dì una parola di sinistra … anche non di sinistra …dì una parola di civiltà
- D'Alema dì una parola … reagisci.
Un’altra considerazione mi sembra importante. Nanni Moretti non si limita a sottolineare l’importanza delle parole, lo fa urlando e prendendo a schiaffi la povera intervistatrice. C’è anche questo nel libro. Ovviamente non ci sono gli schiaffi, ma c’è un invito perentorio a svegliarsi. Il libro vuole suonare una sveglia per il lettore. Il libro ci sprona ad alzare lo sguardo dai problemi quotidiani, dal contingente. È l’invito a prendere coscienza che stiamo vivendo una svolta epocale.
L’obbiettivo del neoliberalismo è l’affossamento del patto sociale inscritto nella nostra Costituzione per sostituirlo con il patto sociale inscritto nei Trattati europei. L’obbiettivo è smontare progressivamente lo Stato sociale per sostituirlo con lo Stato neoliberale al fine di dare una nuova morfologia all’ordine poltico, economico e sociale. I due contratti sociali sono molto diversi e per molti aspetti sono in contrapposizione. Propongono due modelli di società incompatibili, in conflitto tra loro.
Sono anzitutto diversi i soggetti dei due patti. Il soggetto del patto costituzionale è la “persona umana” in tutta la sua complessità supportata dall’impegno dello Stato ad accompagnarla in un progetto di sviluppo e di emancipazione attraverso il lavoro e l’inclusione attiva nella società. Il soggetto del patto neoliberale è “l’individuo” – appiattito nella esclusiva dimensione economica – che persegue egoisticamente e con razionalità economica il proprio interesse personale. Ne ha dato una bella definizione Amartya Sen: un individuo dotato di alta razionalità economica e, nel contempo, un perfetto idiota sociale.
Questo nuovo patto sociale è la realizzazione concreta di una ideologia, una ideologia che non si limita a concettualizzare e a descrivere il mondo in una dimensione ideale, cioè “come sarebbe bello che fosse”, ma si propone di realizzare concretamente un nuovo ordine sociale e, per ottenere questo risultato, l’ideologia deve diventare “potere” e deve essere capace di creare una egemonia culturale in grado di legittimare il potere rendendo senso comune la propria visione del mondo. La catena che ha articolato il percorso di successo del pensiero neoliberale è costituita da una sequenza di anelli: ideologia, potere, egemonia culturale, senso comune.
Un potere che non viene esercitato con la coercizione, ma trova la sua forza nelle regole sottoscritte e nelle narrazioni che propone. Le regole scritte nei Trattati cristallizzano le scelte politiche originarie che sono costituite una volta per tutte; sono immutabili. In questo modo, le regole innescano un pilota automatico che conosce una sola direzione. Non c’è spazio per politiche alternative: possiamo votare, ma non possiamo cambiare le politiche che governano l’economia. Le narrazioni, dal canto loro, mirano a mitizzare il pensiero ideologico che tende così a sovrapporsi al pensiero cosciente, lo sovrasta e lo anestetizza, lo rende miope di fronte a pseudo verità presentate come assiomi, come dogmi che, in quanto tali, non necessitano di essere vagliati alla luce della ragione, non hanno bisogno di essere supportati da analisi, da verifiche e da dimostrazioni e non lasciano spazio al dubbio, sono veri in sé. Racconti che diffondono chiavi di lettura assolutorie delle difficoltà contingenti, racconti rassicuranti e pedagogici volti ad acquisire consenso, a prevenire e a sedare potenziali opposizioni; mirano a convincere, anche in modo subdolo, che l’ordine neoliberale è il migliore dei mondi possibili.
Come parla il neoliberalismo, come racconta se stesso
Una prima considerazione: l’ideologia neoliberale non si dichiara apertamente. Provate a chiedere alla gente comune se qualcuno sa cos’è il neoliberalismo, se sa cos’è l’ordoliberalismo, se ne ha mai sentito parlare. Se hanno mai sentito un politico dichiarare: sono ordoliberale e sono qui per realizzare i principi di questa ideologia. Carlo Galli ha scritto che è stato per 5 anni in Parlamento e non ha mai sentito pronunciare la parola neoliberalismo e tanto meno la parola ordoliberalismo. Io sono stato per 40 anni in una Facoltà di Economia e non le ho mai sentite (provo un po’ di vergogna a dirlo; ma ci sarebbe molto da dire sul ruolo determinante che ha avuto il pensiero economico nel costruire l’ideologia, nel sostenere il potere che l’ha concretizzata, nel consolidare l’egemonia culturale).
Eppure se vogliamo capire le tendenze in atto nella nostra società, dobbiamo capire cosa propone questa ideologia che diventa potere e crea un’egemonia capace di pervadere con i suoi principi l’intera società. Dobbiamo capire perché le regole sono fatte in questo modo e non in un altro; dobbiamo capire cosa ci comunica il potere attraverso le sue narrazioni, attraverso i suoi miti, attraverso le sue parole.
Una seconda considerazione: il potere neoliberale non esplicita i propri reali obbiettivi. Li nasconde. Parla attraverso narrazioni che in alcuni casi sono dei veri e propri miti. Narrazioni manipolatorie, spesso basate su sotterfugi lessicali, che mirano a semplificare, a creare un senso comune, a indurre assuefazione. Produce luoghi comuni affinché siano recepiti in modo superficiale, per quel che appaiono, e siano fatti propri acriticamente. Vuole che le persone si sentano partecipi della narrazione; vuole che il nostro pensiero sia contenuto all’interno degli schemi dentro i quali ci hanno convinti a pensare.
Il libro “The Great Reset”, scritto dall’organizzatore degli incontri del World Economic Forum che si tengono annualmente a Davos, raccomanda di parlare alla sfera emozionale e sentimentale delle persone e non alla sfera razionale. Perciò le narrazioni sono spesso funzionali all’elaborazione di giudizi morali: il debito pubblico è una colpa morale, frutto di comportamenti irresponsabili di chi ha inteso finanziare gli sprechi di una spesa pubblica inefficiente e improduttiva scaricando l’onere sulle generazioni future. Le svalutazioni della moneta erano “competitive”, cioè stratagemmi viziosi per alterare i prezzi e acquisire facili vantaggi a danno dei concorrenti.
Ora dobbiamo espiare, purificarci dalle colpe attraverso la pena dei sacrifici necessari e dobbiamo adottare comportamenti virtuosi, dobbiamo essere austeri, sobri, rigorosi. Detto in altri termini: ci stanno sottraendo le tutele del lavoro e quote del salario diretto, ci stanno erodendo il salario differito (la pensione) e stanno pregiudicando il salario indiretto (il diritto all’istruzione e alla salute), ma la narrazione mira ad abbassare la soglia di percezione delle conseguenze negative apportate dall’ideologia a carico di una parte della società e, alla fine, ci fanno perdere la capacità di imputarle alla loro origine causale, all’ideologia e alle azioni del potere, e finiamo per considerarle la normalità.
Le parole sono importanti: due proto-narrazioni alla base del senso comune
La madre di tutte le narrazioni consiste nella pretesa di convincerci che, nell’evoluzione degli assetti sociali, abbiamo raggiunto la meta finale, la fine della storia. Meglio non si può fare. Certo ci sono problemi, ma viviamo nel migliore dei mondi possibili. Siamo arrivati all’apice della modernità. Non ci sono alternative possibili. Siamo in un mondo win win in cui tutti siamo vincitori. La marea alza tutte le barche anche le più piccole.
Eppure basterebbe pensare che non può esserci un mondo migliore per tutti. Se è migliore per qualcuno lo è a danno di altri. Il potere è sempre potere di una parte contro altre parti. Ma questa semplice verità non deve apparire. Ecco allora che il potere deve nascondere questa verità; deve nascondere sia gli interessi di parte, sia il danno per altri. Soprattutto il danno per i perdenti non deve essere palese e non deve essere imputabile al potere. Il lessico, le narrazioni e la trasfigurazione dei significati delle parole hanno prodotto il risultato di alimentare una narrazione capace di far apparire come razionale e universale un potere di parte che, in realtà, persegue il proprio interesse particolare a scapito di altre parti.
Il potere ci racconta che i conflitti sociali non esistono più perché non esistono più le classi sociali in conflitto tra loro. Non esiste il conflitto tra capitale e lavoro; non esiste il conflitto distributivo perché il mercato opera in modo razionale e dà ad ognuno quel che gli spetta, oggettivamente, in ragione della sua produttività marginale. Viene meno la ragion d’essere della politica. Ci pensa il mercato. L’ideologia neoliberale mira a sostituire il “politico” con l’ “economico”; si propone di di imporre le regole del mercato come regole sociali e la razionalità economica tende a invadere ogni ambito della vita sociale. Ovviamente questo avviene se il mercato è messo in condizioni di funzionare cioè se funziona la concorrenza. La concorrenza funziona se non ci sono aggregazioni economiche e sociali in grado di influenzare e di manipolare i prezzi, questo sia dal lato delle imprese, sia dal lato del lavoro. Devono essere parcellizzate sia l’offerta, sia la domanda. Diceva la Thatcher: non conosco qualcosa che si chiama società, conosco individui che agiscono mossi da un interesse individuale. Dobbiamo essere imprenditori di noi stessi. Tutti abbiamo un capitale da impiegare, un capitale che ognuno di noi può e deve implementare: il capitale umano. Se sei in povertà è perché sei un imprenditore di te stesso che non ce l’ha fatta, che è fallito. È colpa tua. Non sei stato abbastanza “resiliente”, per usare una delle venti parole proposte dal libro.
Un altro mito fondamentale è l’idea che stiamo procedendo verso gli Stati Uniti d’Europa, la terra promessa. Il popolo ebraico impiegò 38 anni per arrivare alla terra promessa e non fu una passeggiata. Noi abbiamo già speso 67 anni – dal Trattato di Roma – e siamo passati attraverso crisi profonde; ma le crisi non sono soltanto inevitabili, sono anche necessarie. Ci hanno spiegato che l’Europa si farà proprio attraverso le crisi, attraverso stenti e sacrifici. Gli ebrei però avevano Mosè, capace di procurare la manna dal cielo e capace di attraversare il Mar Rosso. Per noi è diverso; anzitutto non abbiamo Mosè e soprattutto non abbiamo un popolo; abbiamo una pluralità di popoli che difendono interessi nazionali e molti di questi non ci vogliono proprio andare negli Stati Uniti d’Europa, nella terra promessa. Però la maggior parte delle persone è convinta che, se dobbiamo affrontare problemi e sacrifici, questi sono inevitabilmente legati al fatto che l’unione è ancora incompleta; i problemi sono legati a questa fase transitoria, sono generati da una incompletezza che peraltro è inevitabile in un percorso in fieri. I problemi si risolveranno quando arriveremo alla meta. I problemi e i sacrifici di oggi sono giustificati dai grandi vantaggi che avremo in futuro quando l’unione sarà completata.
Inutile cercare di spiegare che il progetto di creare uno Stato federale non esiste nella realtà. Non a caso si parla di “sogno” europeo. Quel che si è voluto realizzare è un dispositivo diverso e incompatibile con un assetto federale. L’Unione Europea è stata costruita esattamente come l’hanno progettata coloro che hanno elaborato l’ideologia neoliberale nella versione tedesca, l’ordoliberalismo. Ed è un progetto, quello realmente realizzato, che è fondato su principi e regole assolutamente incompatibili con un assetto di tipo federale. Se si volesse edificare uno Stato federale europeo, si dovrebbe demolire l’attuale costruzione e realizzare un altro progetto. Si dovrebbero cancellare gli attuali Trattati e si dovrebbe dare vita ad una assemblea costituente. La narrazione induce invece a pensare che stiamo progredendo lungo un percorso lineare che, passo dopo passo, ci porterà, nella continuità, a realizzare il sogno europeo.
Allo stesso modo, sono costruite, ad esempio, le narrazioni che raccontano come lo Stato sia assimilabile ad una famiglia, oppure che il Paese è assimilabile ad un’impresa che deve essere competitiva, che le crisi sono state causate da un eccesso di debito pubblico, che la spesa pubblica è inefficiente mentre i mercati sono efficienti, che dobbiamo fare le riforme strutturali che, in realtà, sono controriforme, ecc.
Le parole sono importanti. Chi pensa male parla male
Chi pensa male (cioè chi elabora un pensiero che nasconde secondi fini non dichiarabili, cioè chi ti vuole ingannare) parla male (cioè manipola il significato delle parole). Detto in termini aulici, si può dire che nel lessico del neoliberalismo viene prodotta una discrasia tra significante (la parola) e significato (il messaggio che si vuole trasmettere attraverso la parola). Detto in termini più semplici, il neoliberalismo parla con “lingua biforcuta”: propone un pensiero che nasce con un vizio d’origine; è un pensiero viziato perché promette ciò che non può e non vuole mantenere; è un pensiero ingannatore che persegue un fine nascosto che non si vuole dichiarare. E, per conseguenza, parla male nel senso che distorce le parole fino a proporre vere e proprie truffe lessicali. Snatura il significato delle parole; usa parole distorte per far loro rappresentare una torsione della realtà, una realtà alterata.
Se il potere vuole tagliare la spesa pubblica al fine di contenere la domanda interna per ridurre le importazioni, per contenere i salari attraverso la disoccupazione e quindi ridurre i costi delle imprese a sostegno delle esportazioni, la narrazione non dice esplicitamente: dobbiamo tagliare la sanità pubblica, togliere fondi all’istruzione, ridurre le pensioni. La narrazione è un’altra: dobbiamo finalmente assumere comportamenti virtuosi, dobbiamo tagliare quella cosa tanto improduttiva che è la spesa pubblica, dobbiamo ridurre quella brutta cosa che è il debito pubblico contratto, per di più, con l’intento di trasferirne il peso sulle generazioni future. La narrazione usa le parole austerità, sobrietà, rigore, parole che richiamano comportamenti virtuosi, quelli del buon padre di famiglia.
Le parole sono importanti e il neoliberalismo le seleziona con attenzione. Parole vecchie, che descrivono una visione del mondo che il nemico vuole sconfiggere, vengono ripudiate e bandite: se non esistono le parole per esprimere l’alternativa, l’alternativa non esiste. Il lessico del neoliberalismo propone parole ri-semantizzate che gli autori del libro hanno sottoposto ad analisi con l’obbiettivo di dare trasparenza ai messaggi reconditi che esse sottendono e veicolano.
Dobbiamo reagire. Bisogna trovare le parole giuste
Il libro propone un glossario di venti parole con l’intento di smascherare la strumentalizzazione del lessico da parte di chi pensa male e parla male. Ma è anche vero il contrario: chi parla male pensa male. In altri termini: se utilizziamo le parole del nemico, finiamo per pensare come lui e facciamo il suo gioco. Finiamo per pensare secondo categorie dentro le quali il nemico ci ha convinti a pensare. È questa l’egemonia culturale, il pensiero unico, la strategia vincente del nemico: il vincitore capace di convincere i perdenti che stanno vivendo nel migliore dei mondi possibili. Saper riconoscere le narrazioni e saper disinnescare la retorica suadente: è questa la linea di reazione e di resistenza indicata dal libro.
Concludo con una riflessione sul “nemico”. Proviamo a ribaltare il problema e proviamo a rispondere a questa domanda: chi è il nemico del neoliberalismo? Non lo possiamo dedurre immediatamente dalle sue parole; il nemico non lo dice apertamente. Lo dobbiamo dedurre dai fatti e dall’interpretazione delle sue parole.
Se facciamo questo esercizio ermeneutico, che il libro ci aiuta a praticare, possiamo capire che << il neoliberismo va inteso innanzitutto come un progetto politico finalizzato a indebolire il mondo del lavoro, a desovranizzare e de-democratizzare gli Stati, a ridurre la capacità delle masse di incidere sui processi economici e a consegnare le leve di politica economica a istituzioni sovranazionali che usano lo Stato per avanzare gli interessi dei ceti dominanti >>(Thomas Fazi).
Il lettore del libro potrebbe così prendere coscienza di essere lui stesso il nemico del neoliberalismo. È a molti di noi che il neoliberalismo ha dichiarato guerra. Il libro ci sprona a reagire, a rifiutare l’abito di “individuo economicamente razionale e perfetto idiota sociale” nel quale l’ideologia neoliberale ci vuole costringere. La prima forma di reazione consiste nello smascherare le parole mistificatorie. Poi dobbiamo ritrovare le parole giuste, che siano anzitutto le parole della “persona umana” cui si rivolge la nostra Costituzione, parole rispondenti ad un principio di verità, parole legate alla nostra storia, alla nostra cultura, parole che rispondano ad un principio di civiltà e di giustizia sociale.
Commenti
Posta un commento